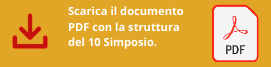- Dall’educazione interculturale all’educazione transculturale
In questo contributo si intende delineare un nuovo modello di inclusione nella scuola a partire dalla nuova concettualizzazione della «cultura», intesa come relazione tra culture, propria del modello di «educazione transculturale» e prendendo le distanze dall’«educazione interculturale», così come si è delineata in Europa nei primi anni Ottanta.
Dopo quasi quarant’anni dalla formulazione dell’interculturalità nei programmi della Comunità Europea (Rey, 1986, pp. 35-47; Perotti, 1986, pp. 72-93), dopo tante sperimentazioni, si deve riscontrare che il tasso di mortalità scolastica degli studenti immigrati di prima e seconda generazione è in crescita, unitamente ai fenomeni di disagio e di esclusione (Moro, 2004; Gorski, 2009; Gavazzi e Zampella, 2009; Ellerani, 2015; OCDE, 2016a; OCDE, 2016b; Ventura, 2012; Malusà e Tarozzi, 2016; Lerin, 2018, Malusà, 2019, 2020).
Tesa, da un lato, a riconoscere le «differenze» e, dall’altro lato, a rimuoverle in una prospettiva «universalista», ma con una forte accentuazione europeista/eurocentrica (Palaiologou e Dietz, 2012), la pedagogia interculturale è stata giustamente definita una «pedagogia paradossale» (Clanet, 1993, pp. 135-136). Fra le due tendenze, alla fine ha prevalso quella universalista, che ha staccato gli immigrati dal loro retroterra culturale, e con il risultare, alla fine, assimilazionista, tesa a trasmettere i contenuti culturali del paese di accoglienza (Demetrio, 2003, p. 177).
Per la prospettiva transculturale la relazione fra culture è intrinsecamente dialogica: nulla è mai completamente “altro”; l’identità è necessariamente «plurima» (sia come singolo sia come comunità). Il prefisso trans di transculturale può rimandare sia all’azione di attraversare o passare da una cultura ad un’altra sia alla dimensione che si trova al di là di tutte le culture, ovvero rimanda a ciò che può accomunarle (Forestal, 2008) e, ancora, come azione didattico-educativa tesa a facilitare la presa di coscienza che tutte le culture sono esposte all’ibridazione e alla contaminazione.
Visti i limiti di spazio, in questa sede mi propongo di prendere spunto dai recenti orientamenti emersi nella filosofia politica, nell’antropologia e nella psichiatria transculturale per trarre le necessarie inferenze pedagogiche per la prassi educativa mirata alla formazione dei docenti, alla ‘revisione’ dei curricola, a tessere legami tra scuola e famiglie migranti, per aiutare al meglio questi studenti, riducendone la fragilità scolastica e rischi tangibili di marginalità e devianza.
2. Dall’identità alla differenza
Viviamo in un’epoca transnazionale, all’interno della quale i confini sono sempre più «porosi» (Benhabib, 2003). La ricerca dell’identità non può più identificarsi solo con la nazione, con l’appartenenza a un paese, con la specificità di una cultura.
A. Appadurai (1996) ha proposto un'antropologia transnazionale individuando cinque dimensioni che contribuiscono alla diffusione di idee e di informazioni (i panorami globali): gli «etnorami», i «tecnorami», i «finanziorami», i «mediorami», gli «ideorami». Queste dimensioni riguardano l'interconnessione, ma anche la fluidità e la variabilità dell’identità dei gruppi nelle aree di scambio globale. Da qui ha inizio una rilettura critica del concetto di «cultura» che non è più ancorata alla relazione ritenuta indissolubile spazio geografico/identità/lingua/etnia/nazione.
Anche per W. Welsh (1999; 2000; 2003) le culture odierne non sono più omogenee e monolitiche (come le sfere), ma mostrano diverse compenetrazioni e interdipendenze (hanno carattere di rete). L’identità degli individui contemporanei è caratterizzata dal fatto che combinano elementi di diversa origine culturale.
Quindi, gli individui di oggi sono intrinsecamente transculturali. Questo non vale solo per i migranti, ma sempre più per tutti. Le identità transculturali hanno il vantaggio di essere in grado di comunicare e connettersi meglio delle «identità monolitiche» prodotte dalle pratiche educative degli Stati-nazione, favorendo l’etnocentrismo e il logocentrismo (Wulf, 2008), perché di solito ci sono sovrapposizioni tra loro che consentono una comprensione reciproca iniziale e che può essere ampliata nelle fasi di comunicazione successive.
La scommessa pedagogica della transculturalità è quella di realizzare le condizioni della continuità e dell’ampliamento di queste fasi nel processo di costruzione dell’identità dei protagonisti dell’educazione non partendo dall’identità per giungere alle differenze, ma presentando le differenze come il vero agente di cambiamento.
3. Inferenze pedagogiche.
Se si intende la cultura come una costellazione di pratiche sociali e narrative, dove l’accento è da porre sulla processualità, potremmo compiere un significativo passo in avanti e intendere l’identità culturale come un’intersezione di strade diverse, una mappatura del sé in continuo divenire e soggetta alla contaminazione e all’ibridismo.
L’esperienza del migrante evidenzia in modo incontrovertibile la permeabilità delle culture, frutto di complessi dialoghi trans e infra territoriali. La presenza dello “straniero” manifesta una sfida al pensiero, che ci obbliga a includere nell’identità, quale suo tratto costitutivo, la relazione con l’alterità.
Un altro che ci cambia perché rappresenta non solo un Esso, oggettivazione le nostre attese sul suo conto, per usare i concetti di Buber, ma è in grado di essere colto come un Tu da incontrare. Una relazione che ci mostra, innanzitutto, che si è qualcuno sempre in presenza di qualcun altro.
La transnazionalizzazione si ripercuote, dunque, sulla cultura, portando la negoziazione e la co-costruzione nell’esperienza culturale (individuale e collettiva) al centro delle vite e delle società e ridefinendo, lungo questo processo, l’identità, quindi, come attraversamento di più testi. Una polisemia che coglie nell’alterità di usi, costumi e linguaggi, un orizzonte di sensi differenti, donati al mondo, che provocatoriamente, ci esortano a riprendere confidenza con il nostro modo di dire ed abitare il mondo.
Come suggerisce D. Demetrio (), sul versante educativo occorre a tale proposito:
- facilitare condizioni idonee perché gli “stranieri” trovino l’habitat di accoglienza più adatto;
- evitare di trasmettere l’immagine del “povero” straniero;
- proporre argomenti che richiamino al prestigio delle culture “altre”;
- valorizzare la lingua dei paesi d’origine;
- invitare a scoprire che le differenze esistono e rappresentano un fattore positivo;
- aiutare ad individuare stereotipi e pregiudizi (anche in chiave ludica);
- presentare temi-guida rinvenibili nelle culture più diverse come – lo si accennava precedentemente – il viaggio, la peregrinazione, la nostalgia, le radici, lo straniero.
In classe è inoltre indispensabile instaurare un clima impregnato di valori come:
- l’accettazione dell’altro, in quanto portatore della dignità umana comune a tutti;
- l’accoglienza intesa come vera apertura verso l’altro;
- la convivenza, cioè disponibilità ad accettare la coesistenza di valori diversi.
Ma ciò che sostanzia maggiormente il dispositivo transculturale sono tutte le occasioni in cui l’insegnante riesce a promuovere:
- modalità di ascolto attivo (non interrompere, porre domande di comprensione, saper cogliere anche i segnali non verbali, i bisogni insoddisfatti);
di dialogo (in termini non solo di imparare a comunicare il proprio pensiero, ma anche di saper riconoscere e gestire i propri sentimenti, le emozioni e le sensazioni corporee);
di incontro (come capacità e possibilità di contatto autentico, sullo stesso piano, da persona a persona nel senso di M. Buber o C. Rogers);
di confronto (riuscire a pensare con la propria testa, accettando anche l’autonomia di pensiero dell’altro.
Una partita dove le regole sono chiare – il rispetto reciproco e il rapporto paritetico – ma nella quale la fine è aperta: può essere il pareggio, la vittoria dell’uno e la sconfitta dell’altro, ma anche la vincita di entrambi).
Se intesa e gestita in tal modo, la presenza in classe di alunni con differenze etniche o culturali, potrebbe rappresentare un’occasione di arricchimento non solo per tutti gli alunni, ma anche per l’insegnante: migliorare curricoli formativi, stili comunicativi, struttura e finalità stesse dei percorsi di insegnamento. Come ricompensa al maggiore impegno, l’insegnante accrescerebbe la propria competenza professionale e umana. Persino l’incertezza diventerebbe una risorsa, stimolando a partire non da soluzioni precostituite, ma da un interrogativo, da un bisogno di cercare percorsi innovativi.
In ultima analisi, per attuare appropriati interventi pedagogici transculturali, occorre un lavoro di formazione incentrato su uno schema inverso a quello abituale: per regolare la rappresentazione degli altri, è necessario agire innanzitutto sulla rappresentazione di sé: la questione che si pone non è più chi è l’altro ma chi sono io stesso in rapporto all’altro. Ogni problema riguardante l’altro dev’essere raddoppiato con l’interrogativo sul “chi sono io”
Dopo il crollo dell’impero sovietico non esiste una sola civiltà (quella occidentale), da propagare sull’intero pianeta e da proteggere dagli attacchi esterni. Nel mondo post-guerra fredda si attesta l’esistenza e la nascita di molte altre civiltà non occidentali, in parte nuove, in parte altrettanto antiche e assiologicamente radicate (come quelle di Asia orientale, Giappone, stati islamici, religione ortodossa, sud America). Perciò la grande sfida del XXI° secolo è (e sarà sempre più) di riuscire a gestire i conflitti di natura religiosa, economica, culturale, sociale e comportamentale che ineludibilmente scaturiscono dal contatto e dalla convivenza – talvolta forzata – fra persone differenti (vedi, per esempio, Irak, Israele e Palestina). Per svolgere bene il proprio compito educativo (oltre che istruttivo), l’insegnante non potrà non prepararsi adeguatamente alla presenza di bambini e giovani immigrati. Prendersi cura di loro, riuscire a coglierne i rischi e le opportunità, non vuol dire solamente aiutare alcuni soggetti “bisognosi” ad inserirsi meglio, ma acquisire competenze ed abilità indispensabili per la propria vita privata e professionale: «l’altro mi guarda e mi riguarda» (Levinas).
Una rilettura in chiave transculturale dei saperi insegnati nella scuola e nell’università consiste nella revisione dei curricoli e dei programmi di insegnamento scolastici (Brunelli, Cipollari, Pratissoli, 2007; Fiorucci, 2008; Luatti, 2009; Santarone, 2012 e 2013).
Per fare qualche esempio: nell’insegnamento della storia vi sarebbe da rivisitare il tema della scoperta/conquista dell’America (Todorov, 1992; Todorov, Baudot, 1997) e degli incontri tra popoli nell’età di Colombo (Abulafia, 2008); vi sarebbe da riconsiderare la vicenda delle crociate anche attraverso il punto di vista degli storici arabi (Gabrieli, 1957; Maalouf, 1989), vi sarebbe da riscoprire la storia stessa del “Mediterraneo” (Braudel, 1977; Riccardi, 1997) come spazio di dialogo e di incontro tra civiltà; sarebbe importante rileggere lo stretto rapporto che lega Europa e Asia (Goody, 2010) sarebbe necessario rivisitare l’esperienza coloniale italiana (Di Sapio, Medi, 2009; Tomasello, 2004); per l’insegnamento della geografia si pensi al ruolo che potrebbe svolgere la conoscenza anche di altre rappresentazioni cartografiche del mondo come, per fare un esempio, quella proposta da Arno Peters (Peters, 1988; Grillotti Di Giacomo, 2008); per l’insegnamento della matematica (Cappelletti, 2000a e 2000b; Ascher, 2007; Supino, 2008) e della filosofia (Bernal, 1997; Melchiorre, 2014; Nkafu, 2003) si pensi alle molteplici influenze culturali che ne hanno determinato lo sviluppo, ecc.; per la musica si pensi alla dimensione interculturale del jazz, del blues e della world music; per l’economia si pensi alle forti correlazioni esistenti fra migrazioni e globalizzazione economica; per il diritto si pensi, solo per fare un esempio, al tema della “cittadinanza”.
Alla luce di ciò possiamo alla fine affermare che:
- l’insegnante/l’educatore/l’operatore transculturale è un operatore di confine;
- la transcultura rappresenta una modalità, un versus, una direzione, un pensiero, un processo da costruire e non solo da “definire” inventandosi “nuove nicchie conoscitive”;
- il terzo millennio può diventare una possibilità/occasione perché confini e dogane non divengano ostacoli ai processi conoscitivi.
Perché, infine, la cultura è le culture!